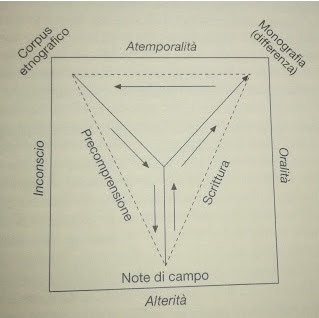A cura di Fulvia D'Aloisio
Ricercatrice,
insegnante di Antropologia culturale e Antropologia delle società complesse presso il
dipartimento di psicologia della seconda Università di Napoli. Si occupa di
antropologia del lavoro e dell'impresa, di bassa fecondità in Italia. Ha
pubblicato Donne in tuta amaranto. Trasformazione del
lavoro e mutamento culturale alla Fiat-Sata di Melfi (Guerini &
Associati), Milano 2003, e Non son tempi per fare figli.
Orientamenti e comportamenti riproduttivi nella bassa fecondità italiana
(a cura), Guerini &Associati 2007. È membro dell'Associazione Italiana
Scienze Antropologiche (AISEA), e dell'American Anthropological Association.
Il campo d’indagine sul mondo del lavoro e in particolare quella branchia
che chiameremo “antropologia d’impresa” è un settore di studi piuttosto
recente, lontano dagli esotismi che hanno caratterizzato gli albori della
disciplina. È in Francia, dove il legame tra antropologia e sociologia è stato
più stretto, che questa forma di riflessione endotica ha dato il contributo
maggiore a questo particolare campo analitico. In Italia invece questo filoni
di studi interno alla disciplina è stato poco esplorato, focalizzando sovente
l’attenzione su quelle pratiche lavorative artigiane e tradizionali, legate al
folklore popolare piuttosto che al mondo del lavoro contemporaneo, alle logiche
aziendali e all’organizzazione d’impresa. È a partire dagli inizi degli anni
’90 che Oltralpe iniziano le prime etnografie sul mondo del lavoro
contemporaneo soprattutto grazie all’impegno di Monique Sélim che con il suo
articolo-manifesto apparso sul Journal
des antropologues del ’91 dal titolo emblematico Désacraliser l'entreprise : un terrain ethnologique banal
contribuisce a sistematizzare concetti e metodologie per approcciare questo
inedito spazio analitico.
Un caposaldo importante nell’impostazione teoretica e metodologica del lavoro promosso da Sélim consiste nel mettere a fuoco una visione globale dell’impresa, invitandoci a diffidare dall’appiattimento focale sulla sola classe di lavoratori salariati. Superare, dal punto di vista dell’analisi antropologica, la visione duale marxiana capitale-forza lavoro, può essere opportuno per cercare di mettere in evidenza quelle che sono le relazioni dialettiche che vengono creandosi fra lavoratori all’interno dell’impresa (antropologia nell’impresa) e provare a fornire una prospettiva più generale procedendo ad una comparazione tra imprese operanti nel medesimo settore (antropologia dell’impresa). Evitare di concepire un’antropologia dell’impresa fondata solo sull’analisi della forza lavoro, tenere in considerazione le dinamiche interne all’azienda, focalizzandosi anche sulle gerarchie e sul management che fanno parte di logiche limpide di organizzazione aziendale, significa per D’Aloisio cercare di analizzare come l’impresa si inserisce e si performa dentro i contesti locali e i tessuti sociali entro cui opera, analizzando i processi lavorativi e le economie che si modellano dentro i sistemi di relazione sociale (Malinowski, Polany) che prendono piede a partire da determinati processi storici. Evitare una sorta di ontologizzazione della nozione di “classe” ripensandone confini e contenuti è un primo doveroso passo per metterci nelle condizioni per approcciare al mondo del lavoro nel XXI secolo, dove alcuni temi cardine in auge nel ‘900 sono stati soppiantati o superati da nuove dinamiche di organizzazione e divisione del lavoro a livello globale.
Un caposaldo importante nell’impostazione teoretica e metodologica del lavoro promosso da Sélim consiste nel mettere a fuoco una visione globale dell’impresa, invitandoci a diffidare dall’appiattimento focale sulla sola classe di lavoratori salariati. Superare, dal punto di vista dell’analisi antropologica, la visione duale marxiana capitale-forza lavoro, può essere opportuno per cercare di mettere in evidenza quelle che sono le relazioni dialettiche che vengono creandosi fra lavoratori all’interno dell’impresa (antropologia nell’impresa) e provare a fornire una prospettiva più generale procedendo ad una comparazione tra imprese operanti nel medesimo settore (antropologia dell’impresa). Evitare di concepire un’antropologia dell’impresa fondata solo sull’analisi della forza lavoro, tenere in considerazione le dinamiche interne all’azienda, focalizzandosi anche sulle gerarchie e sul management che fanno parte di logiche limpide di organizzazione aziendale, significa per D’Aloisio cercare di analizzare come l’impresa si inserisce e si performa dentro i contesti locali e i tessuti sociali entro cui opera, analizzando i processi lavorativi e le economie che si modellano dentro i sistemi di relazione sociale (Malinowski, Polany) che prendono piede a partire da determinati processi storici. Evitare una sorta di ontologizzazione della nozione di “classe” ripensandone confini e contenuti è un primo doveroso passo per metterci nelle condizioni per approcciare al mondo del lavoro nel XXI secolo, dove alcuni temi cardine in auge nel ‘900 sono stati soppiantati o superati da nuove dinamiche di organizzazione e divisione del lavoro a livello globale.
 Un concetto di classe
aderente al nuovo modello di produzione transnazionale è proposto da Sharryn
Kasmir e August Carbonella [1]
i quali, ponendo l’enfasi sulle diverse esperienze lavorative degli individui,
mettono in risalto come in uno stesso ciclo di vita, la biografia di un
lavoratore possa attraversare differenti costellazioni di classe, contribuendo
quindi a fornire una nuova concettualizzazione del termine, tutt’altro che
omogeneo quanto piuttosto notevolmente dinamico, mutevole e per certi versi
sfuggevole. Avvicinarsi allo studio sistematico dell’Antropologia d’impresa,
avendo chiare alcune riformulazioni di concetti classici diviene quindi la
condizione preliminare per guardare a fenomeni globali in parte lontani e
svincolati da tradizionali sistemi analitici.
Un concetto di classe
aderente al nuovo modello di produzione transnazionale è proposto da Sharryn
Kasmir e August Carbonella [1]
i quali, ponendo l’enfasi sulle diverse esperienze lavorative degli individui,
mettono in risalto come in uno stesso ciclo di vita, la biografia di un
lavoratore possa attraversare differenti costellazioni di classe, contribuendo
quindi a fornire una nuova concettualizzazione del termine, tutt’altro che
omogeneo quanto piuttosto notevolmente dinamico, mutevole e per certi versi
sfuggevole. Avvicinarsi allo studio sistematico dell’Antropologia d’impresa,
avendo chiare alcune riformulazioni di concetti classici diviene quindi la
condizione preliminare per guardare a fenomeni globali in parte lontani e
svincolati da tradizionali sistemi analitici.Prendendo spunto da un saggio del 2004 La globalizzazione non esiste (Sélim), D’Aloisio ragiona sugli assetti multinazionali delle imprese all’alba del nuovo millennio, allorché il loro muoversi nello spazio consente alle aziende di performarsi a seconda dei luoghi e dei tessuti sociali in maniera molto diversa e non sempre e non per forza alla ricerca di forza-lavoro a basso costo (esercito industriale di riserva per Marx) ma oggi più che mai, alla ricerca di manodopera ad alta qualificazione, in un’ottica che privilegia maggiormente lavori ad alto contenuto cognitivo. Per l’autrice sono cambiati gli indicatori dell’allocazione e distribuzione mondiale del capitale, sono cambiate le logiche con le quali le imprese si muovono e sono cambiati gli effetti che l’esportazione di lavoro e parti di produzione possono produrre ni territori in cui approdano. Per questi motivi è importante ripensare ai classici modelli che dominano il panorama degli studi sul lavoro e spostarci su un piano più interdisciplinare che sappia cogliere il passaggio da un sistema lavorativo (e analitico) imperniato sulla figura dell’operaio con caratteristiche legate al lavoro manuale e ripetitivo, a un modello di lavoro fondato su caratteristiche e competenze cognitive e affettive. Il cambio di paradigma è sensibile: le richieste delle imprese nei confronti dei dipendenti spingono verso un “saper essere” piuttosto che un “saper fare”.
In Italia i contributi più significativi in materia di analisi del mondo
del lavoro vengono da Cristina Papa che ha cercato di proporre una visione
dell’impresa come un coacervo di processi globali, decisioni, circuiti che
esulano dalla singola dimensione nazionale o globale ma che ritornano al
territorio in cui operano attraverso i lavoratori e le lavoratrici che
all’interno di queste imprese lavorano. A livello internazionale una incisiva
riflessione sullo stato dell’arte circa il nuovo mercato globalizzato del
lavoro è stata portata avanti dall’ILO [2]
che ha cercato di sistematizzare le categorie di flessibilità (esterna e
interna legate rispettivamente al numero secco di lavoratori e alle dinamiche
organizzative e di mobilità lavorativa all’interno di ogni singola azienda) e
di precarietà, così come la definizione di decent
work. Coadiuvato dallo studio di eminenti sociologi come Gallino e Cornero,
il rapporto ILO chiarisce come il fenomeno della precarietà non sia solo il fil rouge delle trattazioni modaiole sul
lavoro ma piuttosto come questa condizione caratterizzi la vita intera del
lavoratore, inficiandone fin nel profondo ogni aspetto sociale e annullando
ogni possibilità di identificazione del lavoratore con una determinata
mansione. Siamo di fronte ad una sorte di rivoluzione copernicana laddove
contrariamente al secolo appena trascorso, ogni illusione di stabilità e
coscienza lavorativa collettiva vigorosa e proattiva viene definitivamente
abbandonata. La nozione di decent work promossa
dall’ILO dovrebbe cercare di spostare il vertice visivo verso una concezione
“sostenibile” di impresa in cui il lavoro non sia generatore di condizioni di
precarietà e di sofferenza ma che possa contare su una continuità del reddito,
rispettando le norme salariali minime stabilite da ogni singolo contratto
collettivo.
Nella seconda parte dell’incontro D’Aloisio ci ha illustrato i percorsi e le traiettorie di ricerca che l’hanno accompagnata negli ultimi 25 anni: la ricerca nel comune di Melfi, in Basilicata, dove ha sede la fabbrica FCA e il progetto interno al Gruppo Volkswagen presso lo stabilimento di Automobili Lamborghini a Sant’Agata Bolognese. L’analisi diacronica di lungo periodo nei due contesti ha permesso all’autrice di portare alla luce quelle che sono le differenti strategie dei due gruppi e le modalità di interazione con i tessuti socio- produttivi locali.
Nella seconda parte dell’incontro D’Aloisio ci ha illustrato i percorsi e le traiettorie di ricerca che l’hanno accompagnata negli ultimi 25 anni: la ricerca nel comune di Melfi, in Basilicata, dove ha sede la fabbrica FCA e il progetto interno al Gruppo Volkswagen presso lo stabilimento di Automobili Lamborghini a Sant’Agata Bolognese. L’analisi diacronica di lungo periodo nei due contesti ha permesso all’autrice di portare alla luce quelle che sono le differenti strategie dei due gruppi e le modalità di interazione con i tessuti socio- produttivi locali.
 A partire dalla decisione di Fiat di negare l’acceso alla ricercatrice
campana allo stabilimento lucano e la susseguente decisione di approfondire la
ricerca nel comune di Melfi, lavorando perciò sulla vita della fabbrica ma
fuori da essa, D’Aloisio ci porta a riflettere sulle modalità in cui il campo
viene co-costruito con i propri interlocutori, diventando un’operazione tutt’altro
che neutra, quanto piuttosto una complessa e delicata mediazione tra diversi
attori in gioco. Contrariamente a quanto avvenuto in Fiat infatti, l’accesso
all’interno dell’azienda Automobili Lamborghini è stato proposto e accolto con
favore dal Gruppo Volkswagen che opera con dinamiche aziendali del tutto particolari,
dove la presenza di un sindacato unitario che siede al tavolo con la proprietà e
che è coinvolto nelle scelte manageriali, ha contribuito a facilitarne
l’ingresso e le relazioni con gli interlocutori-lavoratori.
A partire dalla decisione di Fiat di negare l’acceso alla ricercatrice
campana allo stabilimento lucano e la susseguente decisione di approfondire la
ricerca nel comune di Melfi, lavorando perciò sulla vita della fabbrica ma
fuori da essa, D’Aloisio ci porta a riflettere sulle modalità in cui il campo
viene co-costruito con i propri interlocutori, diventando un’operazione tutt’altro
che neutra, quanto piuttosto una complessa e delicata mediazione tra diversi
attori in gioco. Contrariamente a quanto avvenuto in Fiat infatti, l’accesso
all’interno dell’azienda Automobili Lamborghini è stato proposto e accolto con
favore dal Gruppo Volkswagen che opera con dinamiche aziendali del tutto particolari,
dove la presenza di un sindacato unitario che siede al tavolo con la proprietà e
che è coinvolto nelle scelte manageriali, ha contribuito a facilitarne
l’ingresso e le relazioni con gli interlocutori-lavoratori.
Il progetto di ricerca in Automobili Lamborghini si configura come una
proposta autonoma, non commissionata dalla società tedesca, pertanto la
possibilità di accesso sistematico e continuativo agli ambienti di lavoro così
come ad operai e dirigenti, può essere a buon titolo considerato un unicum nel panorama degli studi
dell’antropologia dell’impresa poiché beneficiaria di un modello del tutto
singolare di relazioni industriali. Le scelte metodologiche del ricercatore e
la composizione del suo campo quindi, dipendono in buona misura dalla storia
dell’impresa e dai suoi rapporti aziendali interni ed esterni e non sono e non
possono essere decisioni univoche e statiche dell’antropologo bensì un processo
che comporta inevitabilmente deviazioni, cambiamenti, rimodulazioni in corso
d’opera.
Dal punto di vista delle relazioni industriali e sulla localizzazione di macro- processi di scale globale i casi di Melfi e di Sant’Agata Bolognese sono meritevoli di attenzione per diversi motivi.
Dal punto di vista delle relazioni industriali e sulla localizzazione di macro- processi di scale globale i casi di Melfi e di Sant’Agata Bolognese sono meritevoli di attenzione per diversi motivi.
La sede lucana di Fiat, ultimo stabilimento aperto in Italia prima delle
massicce esternalizzazioni, ha rappresentato il tentativo di superamento del
modo di produzione fordista, introducendo una filosofia di produzione e un’organizzazione
del lavoro inedita nel contesto automotive italiana, ossia quella del
cosiddetto toyotismo giapponese, che intende la propria forza lavoro come
“operai pensanti”, non solo quindi dediti a standardizzati movimenti ripetitivi
ma molto più vicini a quella tipologia di lavoro cognitivo di cui sopra. Resta
da verificare quanto questa nuova spinta proveniente da Oriente sia o meno
riuscito ad attecchire nel particolare tessuto socio-produttivo lucano, uno dei
più poveri d’Italia e d’Europa. L’apertura della sede melfitana ha
rappresentato un rinnovato progetto di graduale abbandono delle grandi
produzioni delle economie di scala, andando incontro a una sempre maggiore diversificazioni
dei prodotti, a una maggiore personalizzazione degli stessi e contrazione della
produzione per fette sempre più di nicchia di mercato. Partendo dalla domanda
di ricerca dell’antropologa su come nuove dinamiche organizzative globali e
mutamenti culturali radicali influenzino il tessuto sociale, economico e
politico locale, risulta ora chiaro come Melfi sia stato un esperimento di come
la filosofia del lavoro Toyota e un nuovo modello di lavoratore, potesse essere
declinato in ambito Occidentale [3].
Secondo D’Aloisio infatti ci sono state ricadute a più livelli nella vita
sociale e culturale della comunità, a partire dal nucleo famigliare con un
notevole aumento dei tassi di divorzi e separazioni, una rifunzionalizazione
delle reti di vicinato, fino ad arrivare ad un nuovo modello di operaio,
diplomato e qualificato [4]
in grado di avere a che fare con un’elevata tecnologizzazione dei macchinari.
Le spinte globalizzatrici, i flussi di capitale, la divisione del lavoro e l'alto grado di conoscenze e competenze tecnologiche e d’avanguardia hanno interessato anche il contesto produttivo meccanico emiliano compreso tra Bologna, Modena e Reggio Emilia ed in particolare la famigerata casa automobilistica Lamborghini nel suo rapporto con la casa madre Volkswagen, che la vede come un unicum nel complesso panorama italiano delle relazioni industriali. L’incontro della cultura Volkswagen con l’expertise metalmeccanico e manifatturiero emiliano e con il sindacato FIOM [5] ha portato in dieci anni ad un raddoppio sia del fatturato dell’azienda sia del numero di lavoratori, ponendosi in ambito europeo come un modello virtuoso in cui la solidità di un gruppo multinazionale si interseca con la l’intelaiatura tecnica avanzata sia in campo di manodopera, sia in campo di rapporti azienda-sindacato a livello locale. Questo sodalizio va ad inserirsi all’interno di una teoria più ampia delle catene globali del lavoro, dove sembra chiaro come risulti indispensabile per produrre valore, lavoro, prestigio e solidità ad un gruppo multinazionale, scommettere sulle relazioni socio-produttive ad alto contenuto cognitivo e tecnologico piuttosto che rifarsi ad una smodata delocalizzazione d’impresa in cerca di sola manodopera a basso costo.
In conclusione, questi esempi etnografici si configurano dal punto di vista dell’analisi antropologica dell’impresa come ciò che possiamo intravedere a livello locale, di come un tessuto economico, culturale, sociale particolare interagisca con movimenti globalizzanti e con grandi gruppi industriali dal carattere multinazionale.
In conclusione, questi esempi etnografici si configurano dal punto di vista dell’analisi antropologica dell’impresa come ciò che possiamo intravedere a livello locale, di come un tessuto economico, culturale, sociale particolare interagisca con movimenti globalizzanti e con grandi gruppi industriali dal carattere multinazionale.
[1] Blood and Fire. Toward a Global Anthropology of Labor, Berghahn Books, Oxford, 2014
[2]
International Labor Organization
[3] Un
particolare turno di lavoro è divenuto famoso nel settore automotive europeo:
Melfi è stato l’unico stabilimento che ha adottato una turnazione 6 su 7 con il
turno notturno di sabato che prevedeva lo smonto la domenica mattina.
L’intensità di lavoro fino ai primi anni ’10 era stimata in 1500 vetture al
giorno, la più alta d’Europa.
[4] I
giovani operai (tutti al di sotto dei 32 anni) venivano chiamati “giapponesi di
Melfi”
[5] Unico
sindacato presente in Automobili Lamborghini